Prometeo
"Prometeo" di Eschilo - regia di Gabriele Vacis - con gli attori della Compagnia PEM - visto al Teatro Menotti il 15 ottobre - recensione di Adelio Rigamonti
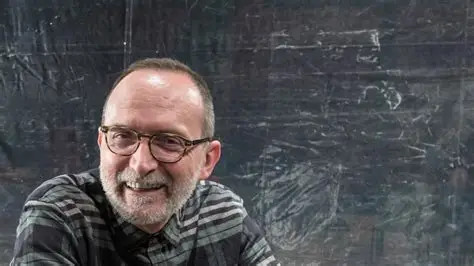
ALLE SOGLIE DEL FUOCO
C'è un momento, nello spettacolo di Vacis, in cui il tempo si sospende. È quando le voci dei giovani attori — i membri dei PEM, Potenziali Evocati Multimediali — sembrano uscire da un luogo remoto, prima che la parola fosse parola, prima che il gesto fosse consapevole. In quello spazio si comprende il non tempo del mito, e si apre il vulnus della ribellione
Vacis non è soltanto regista, ma anche narratore: egli prende posto in un angolo del palco e mi è sembrato essere una sorta di oracolo che invece di profetizzare ricorda. Racconta. Introduce, collega, spiega e la narrazione si arricchisce di interventi che illuminano il mito non tanto come antiquariato, ma come presenza viva dell'umano.
È una voce che sta su una sorta di soglia: non completamente dentro la tragedia classica, non del tutto fuori. È mediatrice tra il pubblico contemporaneo e il testo antico. Permette che il mito risuoni, ma lo fa vibrare con le corde del presente: paura, speranza, sacrificio e rende esplicito non solo ciò che succede nel mito, ma ciò che esso significa qui e ora in questi tempi soggiogati all'imbroglio e percorsi/percossi dalla paura.
Vacis, in questo suo "Prometeo", sceglie di restituire al coro non solo il suono, ma la presenza fisica del/dei mostri, del sacrificio, della divinità e della titanicità di Prometeo. Il coro non è ornamento ma un qualcosa di necessariamente vivo: si muove, canta, soffre ed è soprattutto legame tra divino e umano.
La scenofonia di Roberto Tarasco, più che accompagnare, crea lo spazio stesso in cui il mito abita: un paesaggio di echi e di tempeste, di sospiri e di tuoni lontani. Tale scenofonia insieme ai cori di Enrica Rebaudo danno al suono un qualcosa di splendidamente arcaico: l'eco di un mondo che non ha ancora stabilito concreti confini, un mondo fatto di materia primordiale — fuoco, gelo, divinità incatenate — eppure proiettato verso un'utopia del domani. Vacis lavora con la lingua antica, con la tragedia di Eschilo, ma la "ruba" per donarci non una copia del passato, ma un'illuminazione del presente.
La scena è praticamente vuota, ma necessaria: le presenze si incarnano nei corpi dei giovani attori del PEM, nei canti, nei gesti che oscillano fra rito e sacrificio. La tensione fra ciò che si vede e ciò che si sente riempie lo spazio scenico. Ci sono momenti in cui l'assenza è più forte della presenza.
Mi è parso che Vacis, in questa occasione, corra il rischio di debordare per densità simbolica: per un pubblico meno avvezzo alla tragedia greca, alcuni passaggi possono restare appesi nella forma rituale. La scelta di affidarsi a corpi giovani è un grande pregio (energia, freschezza, vulnerabilità), ma impone al ritmo una dilatazione che può mettere alla prova l'attenzione del pubblico a volte coinvolto da quella che può apparire come ipercinecità del gesto che può rendere la parola meno penetrante. Tali eccessi rendono la tragedia di Eschilo spettacolo non prevedibile ma un poco rischioso. Proprio, forse, come il mito mi sembra richiedere.
Alla fine, mentre le voci si dissolvono in un silenzio che sa di vento e di cenere, si ha la sensazione, mentre per la prima volta dall'inizio si fa buio in sala, che il mito non sia finito. Che il fuoco rubato agli dèi continui a bruciare – non più nelle mani del Titano, ma negli occhi di chi fin lì ha guardato.
Un applauso ai giovanissimi e ottimi interpreti (Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera) che per età, freschezza ed energia a volte scivolano nell'ipercinetismo.
All'uscita del teatro mi sono posto una domanda: chi, oggi, ha ancora il coraggio di rubare il fuoco?
Adelio Rigamonti

